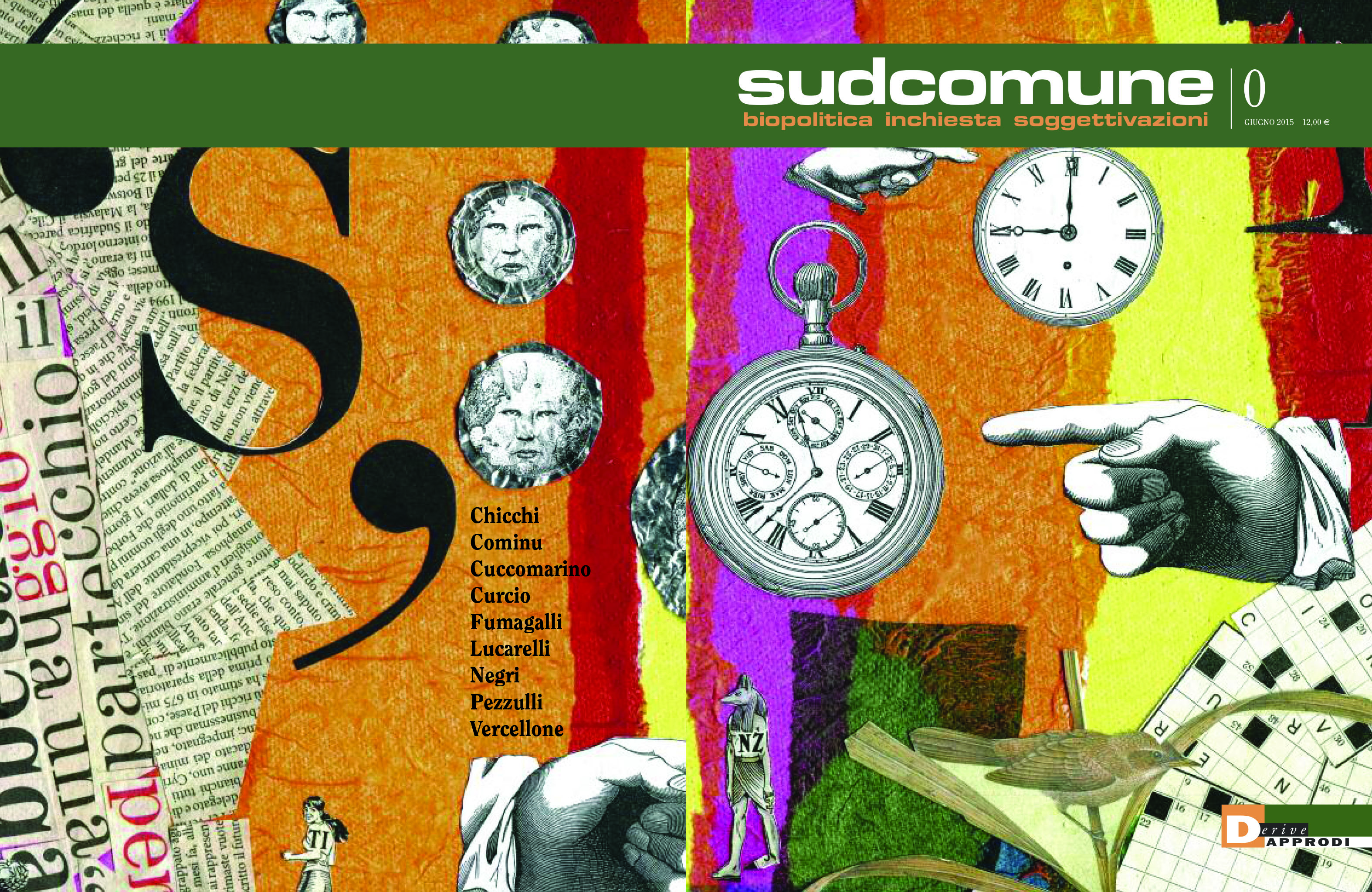di STEFANO LUCARELLI (in sudcomune, n.0/2015)
Alcune ipotesi per un’inchiesta permanente sul (sotto)sviluppo meridionale (I)
0. Cosa significa sottosviluppo del Mezzogiorno italiano? E cosa significa sviluppo del Mezzogiorno italiano? Che tipo di evoluzione sociale ha interessato e sta interessando le classi subalterne nel nostro Sud? La composizione delle classi sociali nel meridione d’Italia dipende in qualche modo dalle politiche pubbliche che interessano lo stesso meridione? Qual è la dimensione politica retrostante all’andamento delle principali variabili di finanza pubblica nel Mezzogiorno? In particolare come può essere letta la dinamica del debito pubblico riferibile alle Regioni meridionali? È possibile un’analisi delle entrate e delle spese pubbliche del Sud Italia che si esaurisca nella dicotomia efficienza/inefficienza?
Sono queste alcune delle domande su cui cercherò di riflettere nei contributi che scriverò per la rivista Sud Comune. Non sono temi facili, ma sono temi urgenti, che rischiano di non essere percepiti come tali: è obiettivamente difficile ragionare di questione meridionale – qualunque cosa possa significare oggi questa espressione – vivendo come me nel Nord Italia. D’altra parte, i territori meridiani non possono dirsi confinati nel Sud Italia. Vi è un’altra difficoltà: nella mia esperienza professionale di economista sono stato costantemente dis-abituato a ragionare sulla questione meridionale. Sono sempre più rari gli studi di economia politica dedicati al Mezzogiorno su cui poter costruire una vera riflessione critica. Sono invece sempre più numerose le analisi che Marx avrebbe definito volgari.
1. Non sarà allora inutile, all’inizio di questo invito all’inchiesta, richiamare la distinzione marxiana fra economia politica (che Marx talora definisce classica, riferendosi soprattutto a Smith e Ricardo) ed economia volgare: “L’economia classica cerca di ricondurre analiticamente le differenti forme rigide e reciprocamente estranee della ricchezza alla loro intima unità e di spogliarle della figura di indifferente giustapposizione; [essa] vuol comprendere il nesso interiore a differenza della molteplicità delle forme di manifestazione. (…) L’economia classica si contraddice occasionalmente in quest’analisi; cerca spesso di intraprendere la riduzione e di dimostrare immediatamente l’identità della sorgente delle differenti forme, senza gli anelli intermedi. Ma questo deriva necessariamente dal suo metodo analitico col quale devono cominciare la critica e la comprensione. (…) L’economia classica ha infine il difetto di concepire la forma fondamentale del capitale, la produzione rivolta all’appropriazione di lavoro altrui, non come forma storica, ma come forma naturale della produzione sociale, concezione alla cui eliminazione essa apre tuttavia la strada con la sua stessa analisi.
Ben diversamente stanno le cose per l’economia volgare la quale intanto si fa largo solo quando l’economia stessa con la sua analisi ha già dissolto e reso vacillanti i propri presupposti, e quindi l’opposizione all’economia esistente già in forma più o meno economica, utopistica, critica e rivoluzionaria. Infatti lo sviluppo dell’economia politica e dell’opposizione da essa stessa creata va di pari passo con lo sviluppo reale degli antagonismi sociali e delle lotte di classe presenti nella produzione capitalistica. (…) Nella stessa misura in cui l’economia penetra in profondità, essa non solo rappresenta delle antitesi, ma la sua antitesi le si contrappone come tale, contemporaneamente allo sviluppo delle antitesi reali nella vita economica della società. Nella stessa misura l’economia volgare diventa consapevolmente più apologetica e cerca di eliminare a forza di chiacchiere i pensieri e, in essi, le antitesi. (…)
L’ultima forma è la forma professorale, che procede ‘storicamente’ e, con saggia moderazione, raccoglie qua e là il ‘meglio’, senza badare a contraddizioni, bensì alla completezza. Toglie lo spirito vitale a tutti i sistemi, da cui elimina rigorosamente il mordente, cosicché si ritrovano pacificamente riuniti nella compilazione. Il calore dell’apologetica è temperato qui dall’erudizione che osserva con benevola superiorità le esagerazioni dei pensatori economici e le tollera solo come curiosità che galleggiano nella sua mediocre poltiglia. Poiché lavori di questo genere appaiono solo quando si chiude il cerchio dell’economia politica come scienza, sono nello stesso tempo le tombe di questa scienza.” (Marx, K., Storia dell’economia politica. Teorie sul plusvalore III, Editori Riuniti, 1993 [1862/63], pp. 536-537).
2. Non è possibile organizzare un’inchiesta sulle condizioni delle classi subalterne meridionali, fermandosi all’economia volgare, né alle esigenze momentanee della discussione politica. Non lo si può fare soprattutto se sono in gioco le mille sfaccettature di un problema strutturale. La questione meridionale è raramente approfondita ed indagata: troppo spesso sembra ormai chiara di per sé, sclerotizzata nelle menti dei decisori politici. Si accetta l’idea volgare che i problemi meridionali siano sintetizzabili efficacemente dallo stato di conti delle pubbliche amministrazioni e che questi siano spiegabili perché sperpero, clientelismo ed inefficienza sarebbero le condizioni strutturali in cui le politiche pubbliche meridionali si perpetuano. Si diffonde la convinzione, terribile ma consolatoria, che dal meridione d’Italia si fugge proprio perché le istituzioni formali ed informali che lì sorgono determinino un’autoselezione. Le Regioni meridionali sarebbero la prova provata dei fallimenti delle istituzioni pubbliche, di un’industrializzazione mal gestita, di programmi di welfare che si risolvono nel peggiore assistenzialismo. Il dilagare della corruzione e della criminalità organizzata avrebbero pertanto trovato terreno fertile proprio in questo stadio demagogico in cui consiste la struttura socio-economica meridionale, fino a divenire fattori culturali. Ciò che permane è il luogo comune, anche se spesso assume una forma professorale.
3. La buona economia politica applicata all’analisi del Mezzogiorno esiste ancora. Ve ne è una parziale traccia in alcuni passaggi dei rapporti SVIMEZ, e negli interventi di qualche studioso isolato. Per esempio Cosimo Perrotta ha recentemente sottolineato come “la mancanza di una visione complessiva” dei problemi del Mezzogiorno impedisca “spiegazioni e interventi adeguati al degrado del Sud di oggi” (Perrotta, C., Cause remote e cause prossime dell’arretratezza meridionale, 2013, http://www.siecon.org/online/wp-content/uploads/2013/09/Perrotta.pdf ). Egli propone pertanto un’analisi di lungo periodo, non affetta da riduzionismo, vizio tipico degli economisti, mostrando l’inconsistenza dello slogan più ripetuto – “più mercato, meno stato” – a rimedio dei problemi del Sud Italia. Lo slogan “non distingue tra stato regolatore, che è necessario, e stato imprenditore, spesso inefficiente. Esso non tiene conto che il mercato senza regole (la famosa deregulation) tende ad auto-negarsi, perché distrugge la concorrenza e fa prevalere, non i comportamenti più produttivi, ma quelli tendenzialmente parassitari o illegali. Questo approccio superficiale fa sì che l’assistenzialismo non venga seriamente intaccato, e continui a prosperare, mentre la concorrenza e il merito vengono ancora mortificati. Si sa che le crisi economiche e morali colpiscono le aree deboli in modo più duro. Tutte le conseguenze negative della crisi si ritrovano ingigantite nel Mezzogiorno: ristagno, delocalizzazione, fuga dei capitali, disoccupazione, povertà, corruzione. Se altrove c’è la crisi, nel Mezzogiorno è arrivato il degrado. Se altrove domina la finanza selvaggia, nel Sud domina la criminalità organizzata” (ibidem, p. 10).
Vale la pena sottolineare due aspetti dell’analisi appena esposta su cui torneremo: l’arretratezza del Sud – la sua debolezza – è qui assunta come evidente. Ne consegue anche che la criminalità organizzata può essere posta in antitesi alla finanziarizzazione. Essa è ricondotta dunque a condizione istituzionale compatibile con realtà socio-economiche arretrate. Come se l’arretratezza fosse in qualche modo indipendente dalla finanza selvaggia.
Perrotta individua, nella storia, tre fattori durevoli dell’arretratezza del Sud:
i) le nuove forme di rendita che hanno nel tempo sostituito le rendite fondiarie e politiche dei grandi proprietari terrieri; quelle che derivano dalla gestione clientelare e nepotistica dei fondi pubblici; dagli appalti pilotati alle nomine dei dirigenti pubblici, dagli enti controllati alle consulenze; le rendite fondiarie legate alla speculazione edilizia; le protezioni corporative delle categorie professionali; i privilegi del ceto politico, dei dirigenti della pubblica amministrazione, dei capi-clientela; la speculazione bancaria e finanziaria; l’evasione fiscale “protetta”; le “rendite dei poveri”, quelle dei falsi invalidi o falsi braccianti, dell’evasione fiscale diffusa degli artigiani, della difesa ad oltranza delle categorie popolari protette a scapito di chi resta fuori;
ii) il doppio codice, dell’omaggio formale alle regole pubbliche, e del loro disprezzo nei comportamenti reali, che disgrega il capitale sociale;
iii) la dipendenza che si manifesta nella fuga dei capitali, nel lavoro sommerso per le ditte del Nord, nell’assorbimento legale dei veleni degli insediamenti industriali funzionali all’industria settentrionale.
Le soluzioni proposte da Perrotta coincidono in parte con le indicazioni presenti nel Rapporto SVIMEZ 2014 sull’Economia del Mezzogiorno (si può scaricare una sintesi del rapporto al seguente link, http://www.svimez.info/images/RAPPORTO/materiali2014/2014_10_28_sintesi.pdf si vedano in particolare le pp. 19-22): “ciò che serve al Sud è nient’altro che quello che serve a tutto il paese: un quadro certo di garanzie; un’amministrazione pubblica efficiente e il controllo di produttività del lavoro pubblico; una giustizia che funzioni in tempi ragionevoli; lotta senza quartiere alla criminalità organizzata e alla corruzione; politiche per estinguere l’evasione fiscale; lotta alle rendite; grandi progetti di sviluppo e occupazione, incoraggiati dallo stato ma che passino per il mercato” (Perrotta, C., cit. p. 12).
4. È senza dubbio ragionevole segnalare – come fa Perrotta – che non ha molto senso parlare di una politica economica specifica per il Meridione, trattando questa realtà come il grande malato dell’italico suolo. Ancor più ragionevole è sottolineare l’inutilità delle politiche di austerity in un contesto di profonda recessione. Il Rapporto SVIMEZ è molto incisivo in tal senso: “Gli effetti della crisi si sono fatti sentire anche al Centro-Nord, e non certo per colpa del Sud; ma anche l’area più forte del Paese rischia di non uscire dalla crisi finché non si risolve il problema del Mezzogiorno, in quanto una domanda meridionale così depressa ha inevitabili effetti negativi sull’economia delle regioni centrali e settentrionali. (…) dopo il fallimento delle politiche di austerità che hanno contribuito all’aumento delle disparità tra aree forti e deboli dell’Ue, è giunto il momento di mettere in campo una strategia di sviluppo nazionale che ponga al centro il Mezzogiorno, e sia capace di coniugare un’azione strutturale di medio-lungo periodo fondata su alcuni ben individuati drivers di sviluppo tra loro strettamente connessi con un piano di “primo intervento” da avviare con urgenza: rigenerazione urbana, rilancio delle aree interne, creazione di una rete logistica in un’ottica mediterranea, valorizzazione del patrimonio culturale.” (SVIMEZ, p. 7).
Tuttavia la messa in campo di un nuovo modello di sviluppo comporta la comprensione delle traiettorie di sviluppo che hanno caratterizzato quell’area. Ciò sembra mancare – o quanto meno resta inespresso – nel Rapporto SVIMEZ. Questo ha soprattutto il merito di porre l’attenzione sulla rigenerazione urbana e l’industria culturale come fattori di sviluppo; di grande interesse è anche la presa di posizione sulla centralità del Mezzogiorno, senza che essa sia giustificata a partire dall’arretratezza economica del Sud. Le politiche per la città (recupero e bonifica di aree dismesse o sottoutilizzate, generare di innovazione sociale con la partecipazione attiva delle giovani generazioni, stimolare la nascita di nuove imprese per la gestione di aree verdi e urbane riqualificate) e per le aree interne (rigenerazione dei borghi con idonei investimenti e agevolazioni fiscali e contributive, promuovere la creazione di filiere energetiche locali strettamente integrate con il processo di riqualificazione, sostenere una strategia di sviluppo della green economy che unisca il mantenimento degli ecosistemi fluviali, la valorizzazione turistica dei territori, la produzione di servizi agricoli ambientali) rappresentano in effetti degli oggetti di riflessione di estremo interesse anche per chi volesse rivendicare nuove forme di cura dei beni comuni urbani; a partire da queste rivendicazioni – ma soprattutto a partire dalla concreta azione di cura esercitabile collettivamente – si potrebbe mostrare l’impossibilità di definire diritti di proprietà pubblica o privata su quei beni (si veda a tal proposito il Regolamento sull’amministrazione condivisa promosso da Labsus, http://www.labsus.org/scarica-regolamento/).
Eppure – a ben vedere – il modello di sviluppo economico cui il Rapporto SVIMEZ aspira è molto distante da un discorso fondato sui beni comuni urbani: si sottolinea infatti la necessità di stimolare la redditività delle aree urbane e delle aree interne attraverso “interventi di natura fiscale e amministrativa (zone franche, zone economiche speciali, ecc) che attraggano imprese e capitali” (ibidem, p. 21). Le tante criticità di un modello di sviluppo così configurato, dipendente in prevalenza dai capitali esteri, sono ben descritte proprio nella relazione di Perrotta: “Nel sec. XII iniziano a insediarsi nel Sud le grandi famiglie mercantili di Venezia, Genova, Firenze, Siena e di tante altre città italiane del centro-nord; e poi anche quelle catalane, greche, ecc. Arrivarono i Mocenigo e i Morosini, i Fieschi e i Vernazza, gli Adorni e i Peruzzi, e tanti altri. Queste famiglie non si mescolarono mai con la popolazione locale, ricca o non ricca che fosse (una delle pochissime eccezioni furono i Doria di Genova). Essi monopolizzarono anche le importazioni di manufatti e l’esportazione dei prodotti agricoli dei feudatari, emarginando i mercanti locali. Monopolizzarono gli appalti produttivi e finanziari. Ed esportarono tutti i loro profitti verso le città di origine, come avvenne (ed avviene) nell’economia coloniale e neocoloniale.” (Perrotta, C., p. 4)
5. Torniamo a questo punto ai due punti critici dell’analisi di Perrotta cui prima abbiamo accennato: l’arretratezza del Sud assunta come evidente e la criminalità ricondotta a condizione istituzionale compatibile con realtà socio-economiche arretrate. È importante innanzitutto verificare l’attualità di un’ipotesi interpretativa scomoda ma determinante: “Il sottosviluppo non è soltanto il ‘non-ancora’ sviluppo, così come voleva l’ ‘ottimismo’ dei classici dell’economia politica che si prolunga ben addentro ai nostri giorni; ma non è neppure il prodotto dello sviluppo, secondo un modo statico, strutturalista, di leggere la fisionomia, a torto ritenuta l’ultima parola del marxismo teorico sul tema. Esso è una funzione dello sviluppo capitalistico: una sua funzione materiale e politica. Sviluppo è infatti quello del potere capitalistico sulla società nel suo insieme, del suo ‘governo’ della società – del suo stato” (Ferrari Bravo, L. e A. Serafini, Stato e sottosviluppo. Il caso del Mezzogiorno italiano, 2007 [1972, Feltrinelli], ombre corte, p. 29 )
In che senso oggi il Mezzogiorno italiano può essere indagato come una funzione dello sviluppo capitalistico?
Il Mezzogiorno è concepibile come un insieme di variabili (il territorio meridionale, i lavoratori meridionali, i disoccupati meridionali, i lavoratori in nero meridionali, i migranti meridionali, i politici meridionali, le famiglie criminali) che rappresentano dei fattori di produzione specifici all’interno di un modello di sviluppo molto diverso rispetto a quello analizzato nel 1972 da Ferrari Bravo e Serafini. Se è probabilmente possibile ribadire che il sottosviluppo non è tanto un mancato incremento nel tempo del prodotto pro-capite, quanto una funzione di piano dietro la quale non vi è l’anarchia delle forze produttive, tuttavia non è più pensabile che la situazione meridionale italiana sia riconducibile alla sintesi statuale esercitata per mezzo degli istituti di programmazione (come invece fu nel’50 con lo schema Vanoni e soprattutto a partire dagli anni ’57-58 per tutti gli anni ’60 con i provvedimenti straordinari per l’industrializzazione del Sud) per controllare la conflittualità operaia. Il contesto macroeconomico in cui viene a definirsi la funzionalità dei fattori di produzione meridionali per un modello di sviluppo transnazionale, è caratterizzato da una resilienza delle istituzioni creditizie e finanziarie Dopo la crisi dei subprime non si è assistito al collasso dei mercati finanziari, piuttosto l’intervento pubblico richiesto soprattutto dagli investitori istituzionali ha comportato una riduzione dell’indebitamento privato e un incremento di quello pubblico. L’austerity europea è l’esito delle logiche finanziarie, infatti le politiche imposte a livello europeo sono state finalizzate soprattutto a creare liquidità a fondo perduto per il sistema finanziario, per evitare l’effetto domino di fallimenti privati. Il meridione d’Italia ha subito nel contempo delle interessanti trasformazioni in relazione alla propria specializzazione produttiva, che non si esauriscono semplicemente nella desertificazione industriale, ma che comportano un’attenta analisi dei processi di terziarizzazione che caratterizzano diverse aree meridionali. Anche la funzionalità della criminalità organizzata che trae linfa dal meridione non può essere compresa senza entrare nel merito delle catene transnazionali della produzione che al contempo si sono andate ridefinendo.
In questo contesto va analizzata la “gestione dell’arretratezza” economica del Mezzogiorno.
(continua…)